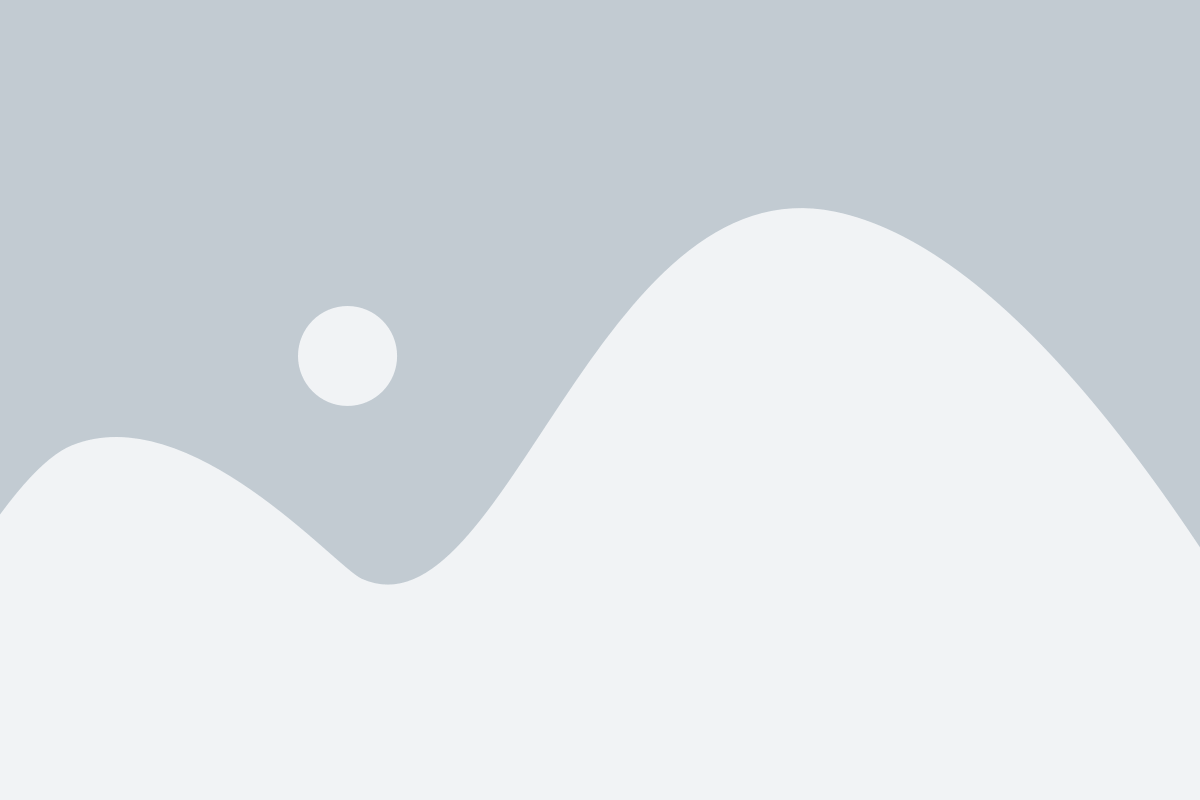Bentrovati nell’entusiasmante mondo della sharing economy.
Luogo in cui il presunto potenziamento di persone ordinariamente disoccupate e la sostenibilità ambientale diventano il mix emozionale con cui aziende “pronte a scivolare” su qualsiasi pavimento fiscale e contributivo nazionale, ci hanno convinto (o quasi) che condividere è “very bello”.
Ho iniziato ad interessarmi di “sharing” nel 2008 quando, accompagnando brand più o meno noti sul mercato globale dei “gadget d’innovazione” ho pensato che la sostenibilità di prodotto potesse diventare un valore per il consumatore anziché un ingombrante obbligo normativo per le aziende. Basandomi su questo principio ho aperto una startup e fatturato abbastanza da poter sviluppare consulenze strategiche in diversi settori di quella tecnologia che oggi popola le nostre tasche, i nostri palinsesti e le nostre menti interconnesse.
Il termine sharing economy comprende una vasta gamma di piattaforme digitali a propulsione tentacolare come Airbnb ed Uber solo per citarne due, ma anche un insieme di attività off-line come le piccole iniziative dei collettivi di ciclo-officine con annessa torteria ed i sistemi aperti di elemosina reputazionale come il crowdfunding.
Insomma dal 1995, anno di fondazione di eBay (allora si chiamava AuctionWeb), fino ad oggi siamo corsi tutti sotto il “tendone” del ricircolo di merci, del maggiore utilizzo di beni durevoli, dello scambio di servizi, della condivisione di attività produttive, i cui messaggi forti sono il significato simbolico positivo della condivisione stessa e l’esponenzialità declinata attraverso l’innovazione tecnologica e sociale (spesso confuse).
Il primo prodotto venduto su eBay dal suo fondatore Omidyar fu un puntatore laser che si era rotto due settimane dopo l’acquisto. Il prodotto, sebbene non funzionante venne comprato da un collezionista a 14,83 dollari ovvero circa la metà di quello che era originariamente costato.
Quello che sta accadendo con il fenomeno della sharing economy però mi ricorda i primi giorni di Internet a larga diffusione in Italia. Se c’è una cosa che accomuna, i nati come me dopo il 1970, è l’eccezionalità del contesto italiano – ben diverso dalla Silicon Valley- in cui molti credevano (e forse credono ancora)che la connessione digitale fosse una leva per l’empowerment, mentre la tendenza a dominare di piattaforme di scala come Google, Facebook o Amazon ci ha perentoriamente restituito uno spunto per ragionare sulla differenza tra putrescenza e progresso.
Le piattaforme di sharing si moltiplicano in tutto il mondo e le città diventano centri di “buone” pratiche di “condivisione” con il comune denominatore, spesso solo ideologico tra i partecipanti, di creare società più giuste, più sostenibili e più socialmente connesse. Tutti valori che nessuno può disconoscere come necessarie nella vita futuribile di sempre, ma ad alto rischio di manipolazione.
Il problema reale, a mio avviso, è creato dallo smistamento nelle città, di migliaia di giovani istruiti e creativi (non c’è un barista a Torino o Milano che non sia anche artista o scrittore o pittore) alla ricerca di una stanza, di un lavoretto, o di una bici per eseguire il lavoretto della gig economy, di una pietanza, ed altre amenità sottraendole di fatto a chi era già lì.
La nuova condivisione si basa gran parte sull’elusione di norme e sull’infrangere la legge sottoponendo i consumatori a prodotti scadenti e poco sicuri.
Dean Baker, economista
Il caso di Foodora a Torino, (azienda tedesca che eroga un servizio di consegna on-demand attualmente in dieci paesi e più di 36 città) in cui i pedalavoratori 4.0 hanno coinvolto direttamente il consumatore per provare ad ottenere un riconoscimento contrattuale dall’azienda, è emblematico.
Il mio obiettivo è guadagnare 200 euro. Convivo con la mia ragazza, ho una borsa di studio. Non ho l’auto, vado in vacanza dai nonni e non mangio spesso fuori
rider, Foodora
La politica ed il welfare tradizionale sono stati completamente bypassati perché assenti ed impreparati alla nuova realtà liquida del lavoro. I lavoratori (per buona pace dei sostenitori della gig economy che interpretano Foodora come luogo dei lavoretti), così come l’azienda con loro, hanno usato l’emotività del consumatore per restituire la non equità della paga oraria e del cottimo per smuovere la coscienza collettiva.
Forse Foodora non è nemmeno sharing, visto che chi incassa è il brand e non chi presta i servizi, ma ciò che conta, e che voglio sottolineare qui, ben oltre i giudizi da tifoseria su cosa è o non è sharing, è il fatto che questa protesta abbia coinvolto anche la frazione del ceto medio non riflessivo, facendo emergere un tentativo di dissimulare la vulnerabilità sociale dei giovani ciclisti indorandola con una patina di presunta orizzontalità.
Comunicato dei rider di Foodora di Torino
La diffusione di sistemi come Foodora, Airbnb, Uber, Just Eat costituisce ancora un problema in sé, perché altera la struttura locale e sociale dei servizi mentre il sistema di governance politica è in grado di apprendere dell’esistenza di un lavoro non tutelato e non normato soltanto dai giornali.
Airbnb ad esempio, crea un reddito aggiuntivo ma riduce il numero di appartamenti disponibili per chi non ha la possibilità di comprarne uno.
Vero è che nel nostro paese ciò impatta solo sul 20 % della popolazione, ma questo gruppo sociale va sacrificato a favore della condivisione? Forse strumenti di housing sociale appositamente creati e finanziati dalle municipalità attraverso l’imposizione fiscale su chi ha un lavoro ancora “tradizionale”, potrebbero essere invece evitati a favore di sistemi di housing sociale diffuso subito attivabili a basso costo, incentivando con strumenti innovativi, ben oltre il canone concordato, i proprietari degli immobili.
E ancora dal mio punto di vista, riconoscendone l’indubbia comodità, attraverso l’utilizzo di servizi come Just Eat e Foodora (che sharing o meno fa parte di un pezzo del processo di acquisto), molti commercianti si illudono di aumentare le vendite, perdendo di fatto il controllo sui clienti finali e livellando il proprio servizio attraverso un meccanismo di estinzione in cui la tipicità del cibo cucinato viene soppiantata dal brand di chi lo consegna.
Lascio agli entusiasti di queste cannibalizzazioni, la retorica sulle sublimi esperienze di ospitare in salotto una coppia di sposini del Texas alla scoperta della nostra cucina tradizionale oppure di restare intrappolati davanti ad un monitor a lavorare, in solitudine sbriciolando sulla tastiera la propria vita ed un contorno di pietanze fredde ciclo-recapitate.
Le piattaforme che spostano il rischio su dipendenti con il pretesto della “condivisione” attuano “sharewashing” che poi è il nuovo greenwashing
Anthony Kalamar
I risultati di tutto questo ad oggi, a mio avviso, non sono ancora promettenti. I posti di lavoro generati sono troppo pochi e quando ci sono, sono un vertiginoso trampolino per le diseguaglianze economiche che si presentano con una certa “ciclicità” ad ogni grande cambiamento sociale.
Se non maturiamo almeno 20 ore al mese, la paga non ci viene corrisposta e si cumula con quella della mensilità successiva.
rider, Foodora
Con un numero di garanzie sufficiente a garantire guadagni decenti e prezzi ragionevolmente bassi, un mondo costruito su di un nuovo modello di cittadinanza in cui è possibile definire il proprio reddito da diverse fonti senza prevaricare la libera concorrenza tra imprese e individui e senza infrangere la legge, potrebbe creare, in un futuro non così lontano dalla marginalità zero di Jeremy Rifkin, una maggiore qualità della vita restituendoci quella libertà che l’era del silicio ci ha tolto.
Foodora oggi però ci ha recapitato insieme ad una gustosa pietanza l’amara verità di un’economia della condivisione ancora troppo predatoria.